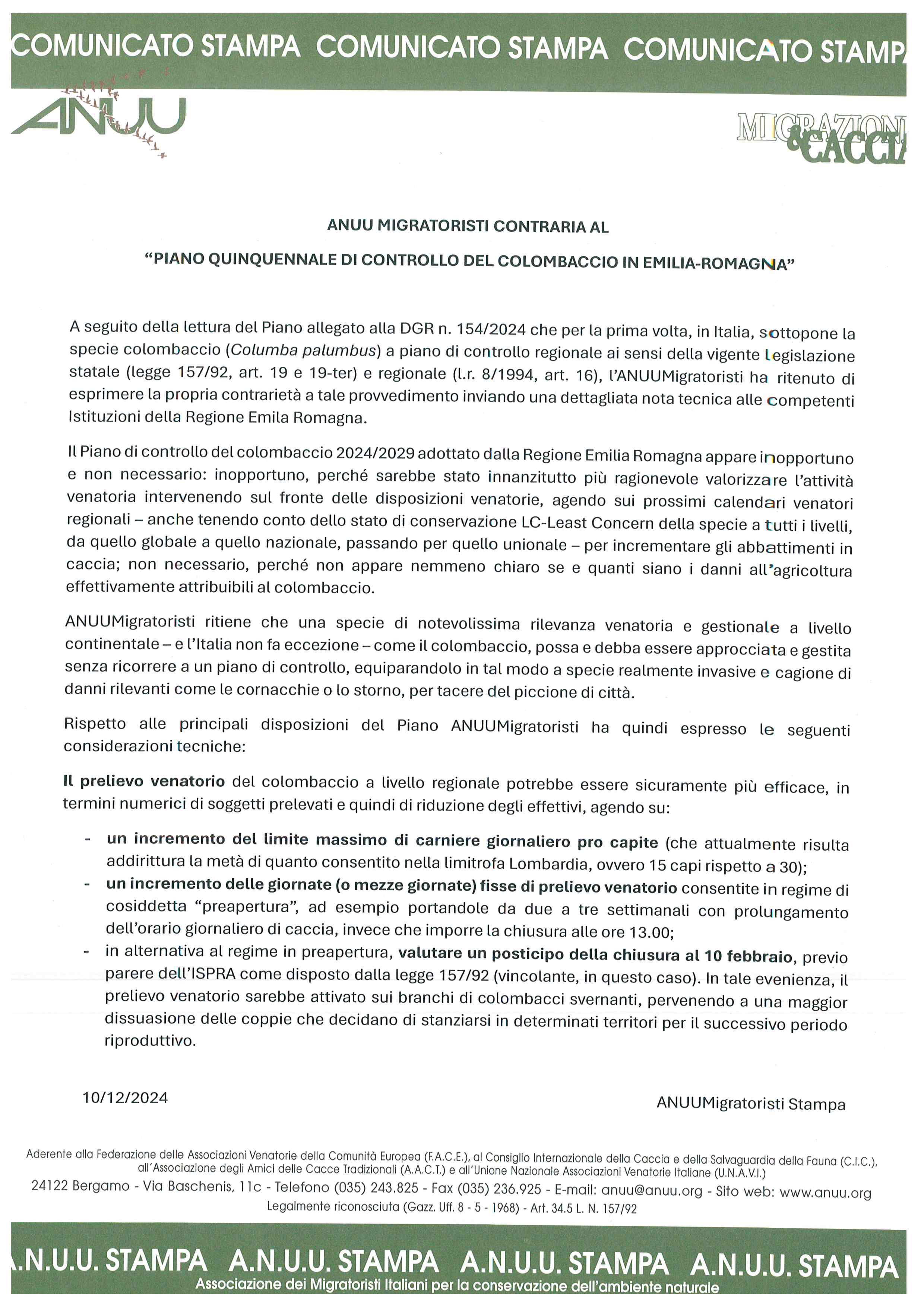LA LEGGE
ULTIMA ORA
LOMBARDIA
STAGIONE VENATORIA 2025/26
PRELIEVO IN DEROGA DI FRINGUELLO E STORNO
(22/08/2025)
https://forms.office.com/e/FHuNwaTbVj per presentare domanda di autorizzazione al prelievo in deroga del Fringuello;
https://forms.office.com/e/jzcYhFJVGB per presentare domanda di autorizzazione al prelievo in deroga dello Storno.
Potrà essere presentata domanda di autorizzazione per entrambe le specie, oppure per una sola delle due.
Sempre online, bisognerà concedere il trattamento dei propri dati personali (informativa privacy).
Si ricorda che tale prelievo si svolgerà dal 1° ottobre al 30 novembre per non più di tre giornate settimanali di caccia e che non è consentito all’interno delle ZPS.
Il cacciatore, una volta autorizzato, dovrà:
- portare con sé, durante l’esercizio venatorio, il decreto dirigenziale, che verrà adottato a settembre, nel quale sarà indicato il proprio codice identificativo e il limite massimo giornaliero e stagionale di prelievo di ciascuna delle due specie;
- registrare i prelievi di entrambe le specie, oltre che sul tesserino venatorio regionale (sigla FL per Fringuello e ST per Storno), anche sul modulo online predisposto da Regione Lombardia da compilare giornalmente al seguente link: https://forms.office.com/e/EdEWXVyW6q
- non potranno presentare domanda i cacciatori che abbiano scelta della forma di caccia in via esclusiva diversa da quella da appostamento fisso;
- potranno essere utilizzati richiami vivi provenienti esclusivamente da allevamento;
- Regione Lombardia, attraverso il monitoraggio giornaliero dell’andamento dei prelievi, potrà sospendere anticipatamente la deroga nel caso in cui sia raggiunto il 90% della soglia del prelievo massimo consentito a livello regionale per le due specie (Fringuello n. 97.637 capi e Storno n. 36.552 capi), per evitare che tale soglia massima (la piccola quantità) venga oltrepassata.
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/agricoltura/fauna-selvatica-e-caccia/ser-prelievo-in-deroga-direttiva-uccelli-agr/prelievo-in-deroga-direttiva-uccelli
SPECIE PROTETTE E PARTICOLARMENTE PROTETTE:
UNO SGUARDO D’INSIEME a cura dell’avv. Francesco Occhiuto
(29/07/2025)
sovranazionale, vietandone la cattura, e assoggettando l'eventuale abbattimento o detenzione a sanzioni penali.

Senza ombra di dubbio l’abbattimento di specie protette costituisce l’atto più deprecabile che un fuori legge (perché l’autore di un simile misfatto non può essere definito cacciatore) possa perpetrare. Come i più sanno, la Legge 157/92, stabilisce pene più severe per le specie “particolarmente protette”, compresa la sospensione della licenza di caccia da uno a tre anni in caso di condanna. Le specie particolarmente protette sono espressamente elencate all'articolo 2 della Legge n.157 del 1992, ma non solo. La Suprema Corte di Cassazione, con una importante pronuncia risalente all’anno 2011 ha considerato come “particolarmente protette” anche quelle citate nell'allegato II della convenzione di Berna. I giudici di legittimità con la sentenza predetta hanno confermato la condanna ad un cacciatore per l'abbattimento di alcuni Frosoni (inclusi nell'allegato II della Convenzione di Berna). In definitiva, rimanendo nell’alveo di questa previsione, lo stesso tipo di condanna varrebbe anche per le altre specie tutelate dalla convenzione: tra i mammiferi l’Istrice e 29 delle 30 specie italiane del sottordine dei Microchirotteri (in pratica tutte le specie di pipistrelli presenti nel nostro Paese tranne il più diffuso Pipistrello Nano), e più di 200 specie di uccelli tra cui: le Strolaghe, alcuni Svassi, le Berte, il Tuffetto, gli Uccelli delle Tempeste, tutti gli Aironi, il Cuculo dal Ciuffo, le Sterne, il Martin Pescatore, il Gruccione, l’Upupa, gli Zigoli, il Frosone, i Crocieri, il Verdone, il Cardellino, il Lucherino, il Gracchio, la Nocciolaia, le Averle, i Rampichini, i Corrieri, i Piovanelli, i Succiacapre, i Rondoni pallido e maggiore, Usignoli, Sterpazzole, la Capinera, la Casarca, la Pesciaiola, l’Oca lombardella minore, l’Oca collorosso, l’Oca facciabianca, le Schiribille, il Voltolino, il Re degli Edredoni, i Gambecchi, le Calandre, il Passero solitario, il Pettirosso, le Pispole, le Cutrettole e vari altri passeriformi ed uccelli acquatici.
L’abbattimento di fauna appartenente alle specie elencate nell’allegato II della Convenzione di Berna del 19 Settembre 1979, relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, ratificata dall’Italia con la legge 5 agosto 1981, n. 503, configura il reato di cui all’articolo 30, lettera b) Legge 157/92 (vale a dire l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da euro 774,00 a euro 2.065,00 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2) in quanto trattasi di esemplari rientranti tra le specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri indicano come minacciate di estinzione menzionate dall’articolo 2, comma primo lettera c) della medesima Legge 157/92.
Cosa accade in caso di abbattimento di specie cacciabili in periodo venatorio non consentito?
In particolare, quale sanzione è prevista per il cacciatore che abbatte un esemplare di una specie cacciabile in un periodo della stagione venatoria in cui non è consentito il prelievo di quella specie?
Alcuni addetti ai lavori sostengono che la condotta in esame rientri nell’alveo della contravvenzione penale ex art. 30 lett. h) della Legge 157 del 1992.
La predetta norma prevede: “l'ammenda fino ad € 1.549 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati”.(…).
Apparentemente, la predetta fattispecie contravvenzionale penale potrebbe dissipare ogni dubbio circa il tipo di “punizione” da irrogare a chi si renda colpevole di abbattimenti di specie animali legittimamente cacciabili ma in un arco temporale della stagione venatoria non previsto (un esempio lampante è dato dall’abbattimento di turdidi oltre le date di prelievo consentite nei rispettivi calendari venatori adottati dalle Regioni), peraltro non è un caso che molto spesso i verbalizzanti in casi del genere contestano ai malcapitati proprio la violazione suddetta.
Sennonché la Corte di Cassazione con la sentenza n. 32058 del 20 Febbraio 2013 ha chiarito la questione statuendo che :“In tema di caccia, l'abbattimento di un esemplare nel periodo della stagione venatoria, ma al di fuori del più limitato arco temporale nel quale è consentita la caccia alla specie cui l'animale abbattuto appartenga, integra il reato di cui all'art. 30, lett. a), legge n. 157 del 1992 e non quello di cui all'art. 30, lett. h), legge n. 157 del 1992 che punisce, invece, l'esercizio dell'attività venatoria non in relazione al tempo, ma all'abbattimento, alla cattura e alla detenzione di una particolare specie.”
Per comprendere in maniera adeguata il tenore della massima giurisprudenziale appena citata è necessario riportare ciò che prevede l’art. 30 lett. a) della legge n. 157 del 1992: “l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da € 929 ad € 2.582 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall’articolo 18”.
La Corte con la predetta sentenza riprendendo una più datata sentenza del 2005 (n. 39287) ha affermato che il reato di esercizio venatorio in periodo di divieto generale previsto dall’art. 30 lett. a) legge 157/92 è configurabile anche nel caso in cui venga abbattuto un esemplare nel periodo della stagione venatoria ma al di fuori del periodo di prelievo consentito per quell’esemplare abbattuto.
Invero l’art. 18 della legge 157/92 prevede il divieto generale all’esercizio venatorio, ma la Cassazione mediante un’interpretazione “estensiva” ritiene che tale divieto possa configurarsi anche in forma “specifica”. Ne consegue che il concetto di divieto generale fissato dall’art. 18 legge 157/92 va inteso con riferimento non solo all’arco temporale nel quale la caccia è sospesa per tutte le specie cacciabili, ma anche in relazione ai divieti specifici per singole specie nelle diverse situazioni territoriali.
Infatti, è cosa nota ai più che le Regioni, tenuto conto dei limiti temporali imposti dalla legge nazionale, possono svolgere un ruolo integrativo rispetto allo Stato operando restrizioni al prelievo venatorio per ogni singola specie cacciabile.
La fattispecie di reato prevista dall’art. 30 lett. h) della legge 157/92 si riferisce, invece, alla diversa ipotesi di “caccia non consentita” non in relazione al tempo, ma alla specie, sicché non vieta l’esercizio della caccia come nell’ipotesi della lett. a), ma l’abbattimento, la cattura e la detenzione.
Nella prassi, però, in situazioni analoghe a quella esaminata dalla Suprema Corte spesso si continua a contestare la lett. h) e non la lett. a) dell’art. 30 legge 157/92.
Nonostante ciò, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali e delle sentenze sin qui descritte (che formano giurisprudenza), ciascun cacciatore ha l’obbligo (anche morale) peraltro fondamentale (ignorantia legis non excusat), di conoscere in maniera precisa e scrupolosa il calendario venatorio e i periodi di prelievo di ogni singola specie cacciabile previsti dalla Regione in cui esercita l’attività venatoria, indipendentemente dal fatto che si tratti di quella di propria residenza anagrafica oppure di un’altra nella quale abbia posto la propria “residenza venatoria”.
Deve essere infine rilevato che le sanzioni penali previste dall’art. 30 lett. a) e h) sono differenti così come sono differenti le pene accessorie previste e pertanto a un cacciatore che (obtorto collo) abbatta un Tordo bottaccio nel periodo in cui lo stesso non può essere cacciato potrebbe essere contestato l’art. 30 lett. a) e ciò comporterebbe non solo una pena notevole, ma in ossequio a quanto disposto dall’art. 32 delle legge 157/92 potrebbe venire sospesa la licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da uno a tre anni.
Per informazioni: f.occhiuto@gmail.com
“Si può mancare il bersaglio mirando troppo in alto, così come mirando troppo in basso”. (T. Fuller)
VALICHI MONTANI: É ORA DI METTER FINE AL PEGGIO
(08/05/2025)
Palumbus
RESIDENZA O DOMICILIO? DOVE VANNO DENUNCIATE LE ARMI? a cura dell’avv. Francesco Occhiuto
(25/03/2025)
Ebbene, a tal riguardo cosa prescrive il Legislatore?
La normativa in materia di armi, per la verità, non prescrive alcunché in merito a eventuali divieti sulla detenzione di armi in luoghi diversi dalla residenza o addirittura in più luoghi differenti, né tantomeno (per fare un confronto sul lato opposto) a obblighi di detenzione nel luogo di residenza. Secondo quanto previsto dall’ultimo comma dell’articolo 38 Tulps (“La denuncia di detenzione di cui al primo comma deve essere ripresentata ogni qual volta il possessore trasferisca l’arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia. Il detentore delle armi deve assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza”), il solo aspetto fondamentale da conoscere alla perfezione è che le armi siano denunciate nel luogo nel quale effettivamente si trovano. Inoltre, secondo quanto previsto dagli articoli 20 e 20bis della legge 110/75 occorre che, indipendentemente dal luogo nel quale siano detenute le armi, sia assicurata la diligenza (del bonus pater familias) nella loro custodia. Vale a dire secondo la capacità di discernimento dell’uomo medio, infatti, secondo costante giurisprudenza di legittimità, (in particolare Suprema Corte di Cassazione I Sezione, sentenza n.1868 del 21 Gennaio 2000) “l’obbligo di diligenza nella custodia delle armi come previsto dall’art. 20 della legge 18 Aprile 1975 n.110, quando non si tratti di soggetti che esercitino professionalmente attività in materia di armi ed esplosivi, deve ritenersi adempiuto alla sola condizione che risultino adottate le cautele che, nelle specifiche situazioni di fatto, posso esigersi da una persona di normale prudenza, secondo il criterio dell’ “id quod plerumque accidit”. Quindi, per esempio, non è affatto una lungimirante idea quella di decidere di tenere (e denunciare) un fucile nella casa di campagna, nel momento in cui la casa stessa resti disabitata per lungo tempo e non siano peraltro adottate le necessarie cautele di sicurezza. In caso di furto delle armi, in un caso del genere, si rischia seriamente di essere denunciati (senza biasimo alcuno) per omessa custodia di armi.
Per denunciare le armi quante denunce servono?
Nel caso in cui le armi siano tutte detenute in un unico luogo, diverso dalla residenza, la modalità di denuncia delle armi non differisce in alcun modo dalla consueta procedura. Si pone tuttavia l’interrogativo su cosa fare nel caso in cui si verifichi l’occasione di avere armi denunciate in due luoghi differenti, che ricadano sotto la competenza di due differenti organi periferici di pubblica sicurezza (per esempio, due stazioni Carabinieri in due diversi paesi o una stazione Carabinieri e un Commissariato di zona e così via). In questo caso, in teoria, le opzioni potrebbero essere due: una sola denuncia, nella quale siano riportate le caratteristiche di tutte le armi detenute e tutti gli indirizzi nei quali sono detenute, oppure due denunce distinte, suddivise a seconda dell’indirizzo di detenzione e della relativa autorità di Ps competente.
La lettura dell’ultimo comma dell’articolo 58 del regolamento di esecuzione al Tulps fa propendere per la prima soluzione: “Chi denuncia un’arma deve anche indicare tutte le altre armi di cui è in possesso e il luogo dove si trovano, anche se sono state precedentemente denunciate”. A questo punto, appurato che il documento debba essere uno solo, è opportuno che esso sia notificato a entrambe le autorità di pubblica sicurezza competenti (ciascuna per uno dei due indirizzi di detenzione) e che ci si faccia rilasciare copia vidimata da ciascuna di esse.
Per informazioni: f.occhiuto@gmail.com
“I delitti possono restare impuniti, ma non possono lasciare tranquillo chi li ha commessi” (Seneca)
TASSE DI CONCESSIONI GOVERNATIVE
TUTTO QUELLO CHE OCCORRE SAPERE
SULLA VALIDITÀ DEL PORTO D’ARMI USO CACCIA
a cura dell’avv. Francesco Occhiuto
(23/01/2025)
 Un argomento assai spesso dibattuto tra i seguaci di Diana riguarda l’annosa questione della validità del porto d’armi uso caccia (non scaduto) in assenza del pagamento della famigerata tassa di concessione governativa. In effetti, trattasi di tematica molto specifica che, se non attenzionata nel modo opportuno, rischia di generare confusione, esponendo a sanzioni i più disattenti.
Un argomento assai spesso dibattuto tra i seguaci di Diana riguarda l’annosa questione della validità del porto d’armi uso caccia (non scaduto) in assenza del pagamento della famigerata tassa di concessione governativa. In effetti, trattasi di tematica molto specifica che, se non attenzionata nel modo opportuno, rischia di generare confusione, esponendo a sanzioni i più disattenti.
Sul punto, la circolare del Ministero dell’Interno (Circ. Min. Interno nr. 557/PAS7U/008463/10100.A(1)1) datata 20.05.2016 cerca di rispondere in ordine alla fattispecie che qui ci occupa richiamando alcune normative di riferimento.
Al riguardo, viene osservato con la richiamata circolare che la licenza di porto d’armi costituisce, ai sensi dell’art. 61 Reg. T.U.L.P.S., un documento complesso formato dal libretto e dal foglietto aggiunto con le indicazioni delle caratteristiche dell’arma di cui è autorizzato il porto e l’attestazione comprovante l’avvenuto pagamento della tassa annuale sulle concessioni governative nella misura stabilita per il tipo cui appartiene l’arma oggetto dell’autorizzazione.
La mancanza di uno solo degli elementi che compongono la licenza, trattandosi di due differenti atti amministrativi impegnanti due distinte volontà della P.A. che, nel loro contenuto unitario, rappresentano la operatività dell’autorizzazione definitiva al porto delle armi, rende invalida l’autorizzazione, oltre che per la specifica finalità per cui essa è rilasciata, anche con riferimento alle attività connesse alla sua titolarità (es. acquisto armi e munizioni).
A ciò si aggiunge che il pagamento della prescritta tassa non rappresenta un puro adempimento di natura fiscale, dato che l’art.8 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.641 dispone l’inefficacia degli atti sino a quando non siano corrisposte le dovute tasse.
Sulla questione in argomento, si è anche espressa la competente Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa, con nota prot. 954-13036/2011, del 27.04.2011.
Il Ministero dell’Interno prosegue affermando che, con l’entrata in vigore della legge 36/90 (il cui art. 6 ha considerato non più reato il porto di arma da caccia con la licenza per la quale si sia omesso il pagamento della tassa in argomento), il mancato rinnovo annuale del pagamento del tributo, pur causando l’invalidità della licenza, comporta, nel caso di porto d’armi da caccia, la configurabilità di un illecito amministrativo (v. Cass. n. 01553 del 13.06.1990 sez. I).
Del resto, viene ancora osservato dal Ministero, va pure considerato che nella Tariffa annessa al suindicato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (Titolo II, art. 5, note, punto 1) si stabilisce, per la licenza uso caccia, che la tassa deve essere pagata per ciascun anno successivo a quello di emanazione, prima dell’uso dell’arma, e non è dovuta per gli anni nei quali non se ne fa uso. Dunque, nel corso del periodo di validità della licenza medesima, è facoltà del titolare corrispondere la prevista tassa di cc.gg. solo per gli anni in cui intende effettivamente fare uso della propria licenza di caccia.
Con riferimento alla possibilità di utilizzare la licenza di porto di fucile anche per uso di caccia per l’esercizio del tiro a volo, la legge 18 giugno 1969, n. 323 ha previsto che “…è in facoltà del Questore (…) rilasciare a chi ne faccia richiesta (…) apposita licenza che autorizza il porto delle armi lunghe da fuoco dal domicilio dell’interessato al campo di tiro e viceversa…” al soggetto che intenda svolgere l’esercizio dell’attività di tiro a volo “…qualora sia sprovvisto di licenza di porto d’armi lunghe da fuoco concessa ad altro titolo…” (all’epoca per il porto di fucile era ancora vigente la locuzione “anche per uso di caccia”).
Ne discende che l’interessato, qualora sia munito di “licenza di porto di fucile anche per uso di caccia” possa utilizzarla anche per l’attività di tiro a volo, sempreché tale licenza sia efficace e in corso di validità.
Poiché l’articolo 8 del citato DPR n. 641 del 1972, stabilisce che “Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate”, ne discende che, qualora si intenda fare uso della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia per l’esercizio dell’attività di tiro a volo, deve essere corrisposta la tassa annuale di concessione governativa.
Ad analoghe conclusioni deve giungersi anche con riferimento all’utilizzo della licenza per l’acquisto di armi.
Per le considerazioni sopra esposte, conclude il Ministero dell’Interno con la circolare suindicata oggetto di disamina, deve quindi ritenersi che, anche nel caso di acquisto di armi, è necessario che l’utilizzo della licenza sia accompagnato, affinché sussista l’efficacia di tale documento, dal pagamento della tassa sulle concessioni governative prevista dall’articolo 5 della tariffa allegata al DPR n. 641 del 1972.
In conclusione, a parere di chi scrive, a quanto disposto dall’art. 8 del D.P.R. n. 642/1972, che prevede per l’appunto l’inefficacia degli atti sino a quando non siano corrisposte le dovute tasse, cristallizza il fatto che la licenza di porto di fucile uso caccia, seppur avente una validità di 5 anni (6 per quelle rilasciate fino al 13 Settembre 2018), deve ritenersi efficace solo subordinatamente al rinnovo annuale del pagamento delle tasse CCGG. In assenza del versamento, la licenza, seppur ancora valida, non produce effetti giuridici e quindi non è utilizzabile per alcuna attività legata all’uso delle armi. Resta, in ogni caso, titolo valido per la detenzione di armi e materiale esplodente, di cui già si è in possesso, fino alla naturale scadenza dei cinque anni.
Sul tema, sempre importante, delle possibili sanzioni che si rischiano nel caso della mancata osservanza delle disposizioni di legge con riferimento alla fattispecie in esame, deve essere rilevato che la giurisprudenza, non di rado, si è discostata dalle interpretazioni fornite al riguardo dalla richiamata circolare Ministeriale. Infatti, secondo l’attuale orientamento giurisprudenziale, il mancato pagamento delle tasse di concessione governativa per l’anno in corso, per l’esercizio dell’attività venatoria con una licenza di porto di fucile uso caccia, fa incorrere nelle seguenti sanzioni:
- sanzione amministrativa di cui all’art. 31, comma 1, lett. c), L. n. 157/1992;
- sanzione penale di cui all’art. 699 C.p. in combinato disposto con l’art. 15 L. n. 497/1974.
ANUUMigratoristi: bene le modifiche alla 157 approvate con la Legge di Bilancio 2025, ma ora occorre la disponibilità e l’impegno del Governo a condividere e programmare con le Associazioni venatorie le azioni necessarie a garantire un futuro all'attività venatoria in Italia
(17/01/2025)
Con una nota inviata al Ministro Lollobrigida, che ha mantenuto l’impegno che si era assunto in tal senso, ANUUMigratoristi ha ringraziato tutti coloro che a livello di Governo e di Parlamento hanno reso possibile questa modifica.
ANUUMigratoristi ha anche auspicato che ora il Governo e le Regioni avviino subito un coordinamento tecnico-giuridico per prepararsi ad accompagnare l’applicazione pratica delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio prevenendo ed evitando qualsiasi intoppo giuridico-amministrativo che, senz’altro, le associazioni animaliste cercheranno di inventarsi per continuare a disturbare un normale e ordinato svolgimento delle prossime stagioni venatorie.
Nello stesso tempo, ANUUMigratoristi ha evidenziato che però resta ancora molto lavoro da fare per garantire un futuro all’attività venatoria in Italia, affrontando e risolvendo con adeguata progettualità e determinazione tutte le altre problematiche venatorie rimaste ancora sul tappeto.
Basti pensare alla necessità, solo per fare qualche esempio:
- di adeguare la Legge 157/92 nel suo complesso al mutato contesto agro-ambientale e faunistico come strumento di gestione e conservazione;
- di rivedere il ruolo di ISPRA;
- di rivedere la Legge 394/91 sulle aree protette molte delle quali, prive dei requisiti sulle quali sono fondate ed in assenza di una qualsiasi gestione, pongono solo degli inutili vincoli che sembrano perniare sul solo scopo di sottrarre territori alla caccia;
- di avviare concretamente le procedure tecniche e politiche per la revisione dei Key Concepts italiani, come ampiamente appurato, assolutamente anomali ed ingiustificati e dai quali dipendono le date di apertura e chiusura del prelievo venatorio di molte specie;
- di risolvere definitivamente l’assurda questione piombo per l’utilizzo nell’attività venatoria;
- di cancellare il problema valichi non previsto da nessuna disposizione comunitaria;
- di disciplinare l’effettiva possibilità di rifornimento di richiami vivi per l’attività venatoria, per rinsanguamento degli allevamenti e per fiere e sagre, così come previsto dalla Direttiva Uccelli e dalla Guida Interpretativa;
- di prevedere la reale e concreta possibilità di prelievo in deroga a difesa delle colture agricole ed a salvaguardia delle tradizioni culturali locali;
- di garantire un efficace ed agevole controllo, come servizio di pubblica utilità, delle specie problematiche ed opportuniste, alloctone e autoctone, che minacciano l’ambiente, la biodiversità, la zootecnia, l’agricoltura, la sicurezza stradale e ora, con la questione grandi carnivori (orsi e lupi) anche la sicurezza delle persone e degli animali da affezione, cani da caccia compresi, valorizzando la figura del cacciatore come Bioregolatore;
- di garantire controlli corretti ed imparziali sui cacciatori contrastando comportamenti spesso vessatori ed umilianti;
- di normare per prevenire e punire severamente le aggressioni degli ecoterroristi a danno dei cacciatori e delle loro sedi e strutture venatorie;
- di impedire al servizio pubblico televisivo di continuare a fare disinformazione, senza un adeguato contradditorio sull’attività venatoria offendendo pesantemente chi la pratica.
Quanto sappiamo veramente delle armi?
a cura dell’avv. Francesco Occhiuto
(23/07/2024)
 Mi accingo a scrivere queste righe con la consapevolezza di chi sa molto bene che l’argomento che si affronterà è tutt’altro che scontato e quantomai insidioso, soprattutto sul versante delle mutevoli evoluzioni giurisprudenziali che il legislatore pretende di farci ingoiare senza troppo preoccuparsi dei risvolti pratici e interpretativi che di volta in volta ne seguono.
Mi accingo a scrivere queste righe con la consapevolezza di chi sa molto bene che l’argomento che si affronterà è tutt’altro che scontato e quantomai insidioso, soprattutto sul versante delle mutevoli evoluzioni giurisprudenziali che il legislatore pretende di farci ingoiare senza troppo preoccuparsi dei risvolti pratici e interpretativi che di volta in volta ne seguono.
Noi seguaci di Diana, instancabili appassionati e forieri di buone novelle, quanto sappiamo dunque veramente delle armi? Ecco, questo articolo si propone di fornire sull’argomento una sintesi da annoverare in un quadro legislativo generale, senza presunzione alcuna di esaustiva completezza, ponendo l’accento su alcuni degli aspetti più salienti di una materia ricca di interpretazioni (non di rado fuorvianti) e insidie celate anche dietro provvedimenti normativi ambigui.
Sotto il profilo strettamente tecnico, per arma deve intendersi qualunque strumento atto a offendere, per sua destinazione naturale (armi proprie) o per le modalità di impiego (armi improprie). Le "armi proprie" sono quelle da fuoco (pistola, fucile, etc.), da getto (lancia, arco, etc.), da taglio o da punta (spada, pugnale, etc.), batteriologiche o chimiche (in ragione degli aggressivi in esse contenuti), i congegni esplodenti, dirompenti o incendiari (bombe a mano, bombe incendiarie, etc.). Nella categoria delle "armi improprie", invece, rientrano le mazze, i tubi, le catene, i bulloni, le sfere metalliche,etc.
La definizione giuridica, invece, è quella che si desume dal combinato disposto delle norme del Cod. Pen. (artt. 585 e 704) e del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) (art.30), della legislazione vigente in materia e in particolare della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni e integrazioni.
Sotto questo aspetto è possibile operare la seguente distinzione:
ai sensi dell'art. 585 del c.p., agli effetti della Legge penale, per armi si intendono:
- quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa della persona;
- tutti gli strumenti atti a offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo;
- le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti, in quanto espressamente assimilati.
- quelle indicate nel n.1 cpv. dell'art. 585 c.p.;
- le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.
- Ai sensi dell'art. 30 del T.U.L.P.S. per armi si intendono:
- le armi proprie, cioè quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa della persona;
- le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti ovvero gas asfissianti o accecanti.
Ai sensi dell'art. 1, 1° comma della legge 110/75, "sono da guerra le armi di ogni specie che per la loro spiccata potenzialità d'offesa sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico, nonché le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici, i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le bottiglie e gli involucri esplosivi o incendiari".
"Sono invece armi tipo guerra quelle che pur non rientrando tra le armi da guerra possono utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra o sono predisposte al funzionamento automatico per l'esecuzione del tiro a raffica o presentano delle caratteristiche balistiche o di impiego comuni con le armi da guerra" (art. 1, 2° comma, legge 110/75).
Rientrano tra le armi comuni da sparo ai sensi dell'art. 2, 1° comma della legge 110/75:
- i fucili anche semiautomatici con una o più canne ad anima liscia;
- i fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento successivo con azione manuale;
- i fucili con due o tre canne miste, ad anima liscia o rigata, a caricamento successivo con azione manuale;
- i fucili, le carabine e i moschetti a una canna ad anima rigata, anche se predisposti per il funzionamento automatico;
- i fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione anulare, purché non a funzionamento automatico;
- le rivoltelle a rotazione;
- le pistole a funzionamento semiautomatico;
- le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890.
Si considerano armi per uso sportivo (legge 25 marzo 1986, n. 85):
- quelle riconosciute dal Ministero dell'Interno, su conforme parere della Commissione consultiva centrale delle armi;
- quelle, sia lunghe sia corte che, per le loro caratteristiche strutturali e meccaniche, si prestano esclusivamente allo specifico impiego nelle attività sportive (art. 2).
- le armi bianche: strumenti da punta o da taglio (pugnali, baionette, coltelli, spade);
- gli strumenti per i quali sussiste un divieto assoluto di porto (mazze ferrate, bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere);
- bastoni animati.
- antiche (art. 2 lett. b, comma 1 della legge 110/75 ed art. 10, comma 1 della stessa legge) sono quelle ad avancarica e quelle fabbricate prima del 1890;
- artistiche sono quelle che posseggono un particolare pregio estetico per la loro fattura originale, o che provengono da artefici particolarmente noti;
- armi rare sono quelle armi classificabili come pezzi unici o reperibili in pochi esemplari (art. 6, d.m. 14 aprile 1982);
- armi storiche sono quelle legate ad un'epoca determinata, a personaggi o ad eventi di rilevanza storico-culturale (art. 6, d.m. 14 aprile 1982).
- 3 armi classificate come armi comuni da sparo;
- 12 armi classificate come sportive;
- un numero illimitato di armi da Caccia.
Nel caso in cui si volessero detenere più armi rispetto ai limiti numerici previsti per questo tipo di licenza, sarà necessario ottenere una licenza da collezionista.
Una volta entrati in possesso di armi e munizioni, la legge prevede un massimo di 72 ore entro le quali dovrà esserne fatta denuncia ai competenti Uffici di Pubblica Sicurezza o ai Carabinieri.
Una licenza di porto di fucile uso caccia consente di detenere, oltre alle armi nelle quantità sopra elencate, anche i relativi munizionamenti e anche polvere da sparo per ricarica. Sarà, però, necessario denunciare il possesso delle munizioni secondo i seguenti termini:
- quando si possiedono più di 1.000 munizioni spezzate o a pallini o pallettoni;
- cartucce per pistola o revolver. Il limite massimo è di 200 cartucce;
- munizioni a palla unica per fucile a canna rigata. Limite massimo 1500 cartucce che dovranno essere tutte denunciate. Le variazioni in termini di diminuzione non dovranno essere denunciate, quelle in aumento sì.
In tutto questo quadro, non può non essere annoverata una tematica di grande interesse per tutti, vale a dire “l’obbligo di diligenza nella custodia delle armi” come previsto dall’art. 20 della legge 18 Aprile 1975 n.110. Già! Ma ci siamo mai interrogati fino in fondo sul significato vero di questo “obbligo di diligenza” e cosa comporta effettivamente?
Lo scrivente che di mestiere fa l’avvocato ha assistito, non di rado, nell’applicazione della norma suddetta, a interpretazioni forzate, estremiste e veri e propri voli pindarici da parte di chi crede di conoscere alla perfezione tutto e poi, invece, finisce puntualmente con l’essere smentito a suon di provvedimenti e sentenze da parte della Autorità Giudiziaria adita.
Per rispondere alla domanda suddetta, richiamo una eloquente sentenza della Suprema Corte di Cassazione della I Sezione la n.1868 del 21 Gennaio 2000 che ha fatto scuola sul punto: “l’obbligo di diligenza nella custodia delle armi come previsto dall’art. 20 della legge 18 Aprile 1975 n.110, quando non si tratti di soggetti che esercitino professionalmente attività in materia di armi ed esplosivi, deve ritenersi adempiuto alla sola condizione che risultino adottate le cautele che, nelle specifiche situazioni di fatto, posso esigersi da una persona di normale prudenza, secondo il criterio dell’ “id quod plerumque accidit.” (Sempre in questo senso, cfr., fra le molte, Cass. Sez. 1, n. 6827 del 13 dicembre 2012, dep. 2013, Arconte, Rv. 254703; Cass. Sez. 1, n. 47299 del 29 novembre 2011, Gennari, Rv. 251407).
Nella specie, in applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha cassato senza rinvio la decisione con la quale era stata ritenuta la penale responsabilità di un soggetto, il quale aveva tenuto le armi nella propria abitazione, munita soltanto dei normali mezzi di chiusura, in un armadio e in una valigia posta sotto il detto mobile.
In definitiva, occorre essere attenti e scrupolosi nel custodire le armi ma senza farsi ossessionare da comportamenti e condotte che vanno oltre la normale diligenza del bonus pater familias.
Vorrei chiudere, per chi ha avuto la pazienza di leggere fino a qui questo articolo, con una frase di Piero Calamandrei “La libertà è condizione ineliminabile della legalità; dove non vi è libertà non può esservi legalità.”
Per informazioni: f.occhiuto@gmail.com
 E' il periodico quadrimestrale ufficiale dell'Associazione, inviato gratuitamente a domicilio a tutti i soci. Esce nei mesi di aprile, a...
E' il periodico quadrimestrale ufficiale dell'Associazione, inviato gratuitamente a domicilio a tutti i soci. Esce nei mesi di aprile, a... Storie di roccoli e roccolatori. Così si presenta questo nuovo lavoro bibliografico dedicato al mondo dei roccoli, strutture di un tempo ut...
Storie di roccoli e roccolatori. Così si presenta questo nuovo lavoro bibliografico dedicato al mondo dei roccoli, strutture di un tempo ut... Anche quest’anno l’apertura di una nuova stagione di caccia si avvicina.
Nel momento in cui scrivo queste righe è già iniziato il p...
Anche quest’anno l’apertura di una nuova stagione di caccia si avvicina.
Nel momento in cui scrivo queste righe è già iniziato il p... L’abate Girolamo Guarinoni fu accademico, insegnante, poeta e cacciatore del ‘700 vissuto a Gorno (BG). La sua vita viene narrata nel li...
L’abate Girolamo Guarinoni fu accademico, insegnante, poeta e cacciatore del ‘700 vissuto a Gorno (BG). La sua vita viene narrata nel li... Un rapporto che ha attraversato secoli di evoluzione, ma che, nel prossimo futuro, vivrà una trasformazione radicale alla ricerca di un equ...
Un rapporto che ha attraversato secoli di evoluzione, ma che, nel prossimo futuro, vivrà una trasformazione radicale alla ricerca di un equ... Durante la 66ª Assemblea nazionale si è proceduto all’assegnazione del XIV Premio Internazionale Ambiente, con il conferimento dei ricon...
Durante la 66ª Assemblea nazionale si è proceduto all’assegnazione del XIV Premio Internazionale Ambiente, con il conferimento dei ricon...